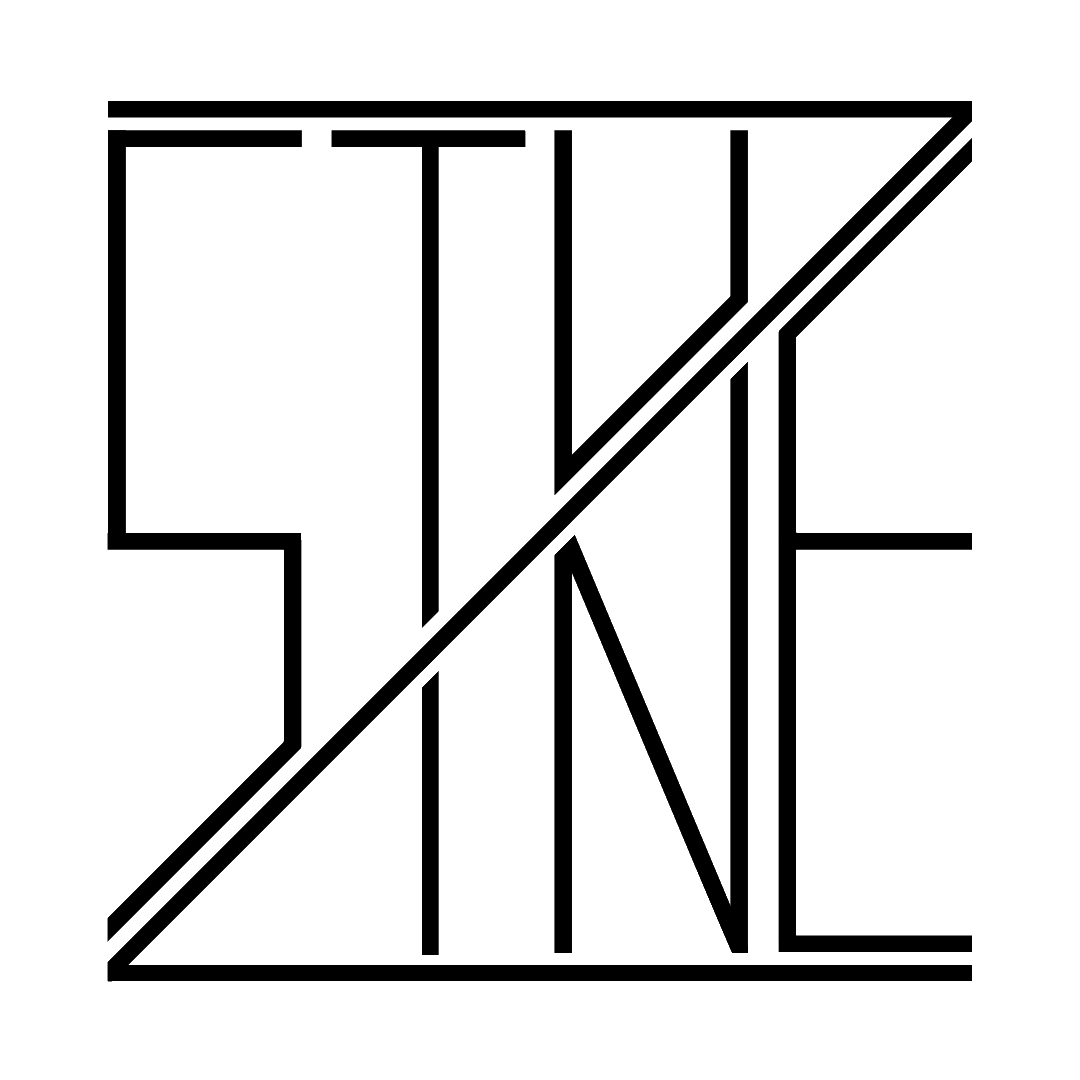In memoria di Cristina Pavesi, vittima della mafia
Era un tardo pomeriggio del 13 dicembre 1990.
Giuseppe parcheggiò la sua Opel Omega nel cortile della questura di Venezia, nei posti adibiti ai poliziotti: abbottonò la giubba blu ceruleo, raddrizzò il colletto inamidato della camicia, stirò con le mani i pantaloni grigio azzurri e si cambiò le Nike con gli scarponi rigidi di pelle nera.
Dallo specchietto retrovisore vide arrivare un’auto: era Carmine. Stavano per iniziare il turno insieme. Lo aveva conosciuto anni prima durante i sei mesi di formazione nella scuola Allievi Agenti di Alessandria.
Giuseppe scese dall’auto e gli andò incontro:
“Beppe, pronto per il turno?” chiese Carmine.
“Sì, manca il cinturone e ci sono” rispose Giuseppe.
Prese il cinturone dal baule dell’Opel e infilò la lingua della fibbia nell’ultimo foro.
Le due porzioni di gnocchi alla romana che aveva mangiato a pranzo le sentiva ancora tutte.
“Dove hai lasciato la pistola?” chiese Carmine.
“Nel mio ufficio, non mi fido a portarla a casa” rispose Giuseppe.
Salirono la rampa che dal parcheggio portava all’entrata degli uffici e timbrarono i cartellini: l’orologio segnava le 16:45. In mezz’ora il treno per Milano sarebbe partito da Santa Lucia.
Arrivò il dirigente di reparto: un uomo sulla cinquantina, i cui anni di esperienza si riconoscevano grazie ai distintivi dorati che portava con onore sulle spalline della giubba blu.
“Carmine; Giuseppe” disse il dirigente. “Al servizio” risposero all’unisono.
“Stasera siete di scorta nel vagone postale del treno in direzione Milano. Voglio massima attenzione, intesi?”
“Al servizio” risposero nuovamente all’unisono.
“Che tipo di merce verrà trasportata?” chiese Carmine. “Per motivi di sicurezza nessuno lo sa, nemmeno noi.
Fate solamente il vostro lavoro, qualsiasi cosa sia” rispose il dirigente.
Giuseppe andò a prendere la pistola nel suo ufficio e la infilò nella fondina.
Il dirigente portò loro dei giubbotti antiproiettili: erano fatti di kevlar, una fibra sintetica ad alta resistenza in grado di assorbire e distribuire l’energia di un proiettile.
Giuseppe e Carmine li indossarono per la prima volta: erano rigidi e pesanti, forse anche a causa dei pannelli di metallo posizionati su fianchi, torace e schiena: un’ulteriore misura di sicurezza per dissipare il colpo dei proiettili.
Una volta pronti, uscirono fuori: era già buio.
Due agenti della marina li stavano aspettando nella lancia, un’imbarcazione robusta e di dimensioni medie, progettata per operazioni di pattugliamento e pronto intervento: Carmine e Giuseppe, sempre per motivi di sicurezza, non potevano andare in stazione a piedi quella sera.
La tratta fu breve.
La lancia si fece poderosamente strada tra le acque della laguna verde petrolio e Giuseppe, che soffriva di mal di mare, si pentì nuovamente di aver mangiato quelle due porzioni di gnocchi alla romana.
Arrivarono in stazione e andarono subito alla Polfer, l’unico reparto di polizia ad operare nelle stazioni e lungo la rete ferroviaria.
“Buonasera colleghi” disse un ragazzo sulla trentina, circa l’età di Carmine e Giuseppe. “Buonasera” risposero i due.
“Queste sono le armi che dovrete usare stasera, prestate attenzione” gli raccomandò il ragazzo.
Erano due Beretta M12, due mitra: armi automatiche a medio raggio progettate per offrire una potenza di fuoco significativa in situazioni ad alto rischio.
Giuseppe era preoccupato, sapeva bene come usare un’arma di quel calibro perché lo aveva imparato al poligono, ma perché un’arma così potente?
I due si misero i mitra a tracolla, posizionandoli sul petto. Uscirono dalla Polfer e andarono al binario 13.
Il treno era già lì e l’orologio segnava le 17:14.
Erano in perfetto orario.
Salirono sul vagone subito dopo quello di testa: era simile a quelli post-bellicum, in acciaio dai colori rosso e bianco sbiaditi, capace di sopportare carichi pesanti e condizioni di viaggio intense.
Ma non era blindato. Era semplicemente un carro chiuso, senza finestre.
Le uniche vie d’uscita erano le due porte a battente, una anteriore e una posteriore, progettate per l’accesso al carico.
C’erano tre sezioni: una frontale, dove c’erano i tre addetti alla posta, una centrale con banchi e scaffali per lo smistamento della corrispondenza e una posteriore con spazi di stoccaggio e la porta d’uscita, dove c’erano Giuseppe e Carmine.
I sedili erano limitati al solo personale. Il treno partì alle 17:15.
“Beppe, vuoi una lattina di cola?” chiese Carmine. “Sì, grazie. A pranzo ho mangiato gli gnocchi alla romana di mia madre e mi hanno fatto una gran sete”.
“E quando pensi di invitarmi a pranzo da tua madre?”.
“Quando vuoi, sai che sei sempre il benvenuto”.
Giuseppe iniziò a sorseggiare la sua bibita, nella speranza che potesse aiutarlo con la digestione del pasto.
“Beppe, ti ricordi le schifezze che ci davano in mensa ad Alessandria?”. “Come dimenticarle”.
Giuseppe si ricordò la sera in cui lui e Carmine si erano conosciuti.
Era appena arrivato ad Alessandria, il giorno dopo sarebbero iniziate le lezioni. Si sentiva a disagio in quel posto, non conosceva nessuno e soprattutto non era mai stato un tipo particolarmente estroverso.
Al contrario di Carmine, lui sì.
Quella sera Giuseppe aveva un certo languorino, sapeva che la mensa era un servizio incluso e quindi si avviò a mangiare qualcosa: la luce fredda e un po’ asettica che si rifletteva sui pavimenti lucidi, i muri verde oliva macchiati dall’umidità, il buzz di voci sovrapposte. Tutto lo faceva sentire fuori luogo.
Poi una voce ovattata:
“Ciao, posso sedermi qui con te?
Mi chiamo Carmine, sei appena arrivato?” “S…sì, da poco.
P…iacere, io…sono Giuseppe”.
“Molto lieto Beppe, posso chiamarti così?”. “S….ì”.
“Tu puoi chiamarmi Mino, se vuoi”.
Un rumore stridente lo riportò alla realtà.
“Mino, cos’è stato?” “Non lo so Beppe”
“Il freno d’emergenza” rispose uno dei funzionari postali. “Strano” rispose un altro, “Non doveva fermarsi così lungo”.
Il giorno prima gli addetti alla Polfer avevano fatto delle prove per vedere quanto avrebbe impiegato il treno a fermarsi in caso di imprevisto: avevano disposto un pallone bianco in mezzo ai cespugli e, una volta raggiunto, avevano tirato il freno d’emergenza per vedere dove si sarebbe arrestato il convoglio ferroviario.
“Potrebbe essere un pericolo” continuò un altro.
Giuseppe si spostò dalla sezione posteriore per raggiungere quella frontale dove c’erano i postini.
Aprì leggermente la porta anteriore.
Sentì solo un rumore elettrico di cavi, poi più nulla.
Il sole era ormai tramontato definitivamente e il cielo era di colore indaco. “Dove siamo?” chiese Giuseppe voltandosi verso uno degli addetti. “Zona Vigonza” rispose.
Giuseppe ritornò a guardare fuori con occhi da falco: niente.
Attorno a lui, oltre la massicciata, le piante pioniere avevano colonizzato i confini poco curati di vasti campi anonimi.
Ad un certo punto si sentì una voce amplificata e distorta, forse proveniente da un megafono:
“Arrendetevi e fate scendere i civili” la voce era maschile.
Giuseppe intravide sette sagome avvicinarsi. Si voltò vero Carmine:
“Mino, ci sono sette uomini che si stanno avvicinando”.
Carmine non rispose.
“Guardate che qui dentro c’è la polizia” rispose Giuseppe alla richiesta dell’uomo, forse il capobanda.
Nessuna risposta, solo il costante rumore elettrico di cavi.
“Siamo armati” continuò Giuseppe.
Cominciò il Redentore: colpi su colpi iniziarono a traforare come grandine l’acciaio del vagone postale.
Giuseppe si buttò per terra. Carmine iniziò a sparare senza mira. “Mino, che fai?”, chiese Giuseppe.
Carmine continuava a premere il grilletto imperterrito, gli occhi sbarrati. Ancora nessuna risposta.
“Non fare fuoco qui dentro” continuò Giuseppe. “Mino, i proiettili rimbalzano!”.
Carmine smise di sparare.
Di nuovo il suono forte e deciso di quei colpi provenienti da fuori: Giuseppe se ne intendeva di armi e sapeva che quelli erano i suoni prodotti da dei fucili d’assalto, più nello specifico da kalashnikov.
Ad un certo punto i colpi cessarono.
Giuseppe si guardò intorno: il vagone era diventato un colabrodo; gli addetti postali erano immobili a terra.
Si sentì lo stomaco appesantito, ma questa volta non per colpa degli gnocchi alla romana di sua madre.
Erano vivi o morti?
Non riusciva a capirlo.
Poi un altro colpo, più forte.
Non erano più fucili d’assalto ma un’arma anticarro perforante, una di quelle usate nei combattimenti terra-terra.
Il fumo pian piano si disperse: l’acciaio si era perforato.
Nella porta anteriore, vicino alla porta a battente, c’era un enorme buco.
Giuseppe guardò con faccia stranita verso il collega, non capiva:
Forse credevano che il vagone fosse blindato.
“Scappiamo” disse Carmine.
Giuseppe lo guardò.
Stranamente non ci aveva pensato.
Scesero dalla porta posteriore.
Giuseppe diede un’ultima occhiata ai postini a terra: forse erano morti, forse impauriti.
Iniziarono a correre lungo la massicciata.
Presero i mitra e cominciarono a sparare: ad ogni colpo si formavano fiamme di color vermiglio di circa mezzo metro.
Non era una mossa astuta.
Decisero di separarsi, gettandosi in mezzo alla sterpaglia.
Giuseppe non vedeva niente e si affidò agli altri sensi: un aroma terroso e muschiato; la pelle pruriginosa.
Sentì un altro treno avvicinarsi e provenire dai binari opposti: era il convoglio che da Padova andava in direzione Venezia.
Il treno si fermò in direzione parallela a quello da cui Carmine e Giuseppe erano scesi poco prima: i macchinisti avevano l’obbligo di fermare il treno quando vedono un altro treno di linea fermo senza alcuna giustificazione.
Ma non accadde nulla e il treno ripartì poco dopo: i banditi, sempre con le “buone maniere”, avevano ordinato di procedere. Un altro colpo.
Una fiammata altissima e potentissima illuminò per pochi istanti quella zona anonima; i vetri delle case limitrofe si frantumarono a km di distanza a causa del movimento d’aria.
Poi il finimondo: urla; grida; pianti.
C’erano cumulus di fumo provenienti da entrambi i treni.
Giuseppe si alzò illeso, quel treno arrivato poco prima aveva fatto da scudo.
Ricominciò a camminare, mosso dalla convinzione di poter riuscire a dare una mano a quei poveri civili.
Poi il tacito accordo: un incontro faccia a faccia con uno dei banditi. Era vestito interamente di nero, il volto coperto dal passamontagna. “Chi sei?” disse il bandito.
“Chi sei tu” rispose Giuseppe.
Impossibile non lo avesse riconosciuto, il cinturone bianco della divisa era catarifrangente.
Nessuna risposta. Nessuno sparò.
Ad un tratto un suono stridente di sirene: qualcuno aveva avvisato i soccorsi. Il bandito scappò.
Giuseppe continuò a camminare nella direzione opposta, lasciandolo andare.
“Beppe… Beppe sei tu?” domandò una voce.
Giuseppe vide un uomo avvicinarsi, la cintura bianca catarifrangente.
“Sì, andiamo”.
Poi non aggiunse altro. Ritornarono verso il vagone del treno.
Videro altre cinture bianche catarifrangenti, altri poliziotti venuti a soccorrere. Stavano parlando con i postini: erano lì in piedi, ancora vivi.
Giuseppe tirò un sospiro di sollievo.
“Dobbiamo portarvi in centrale” disse uno dei colleghi.
Era Checco, un agente investigativo; Giuseppe lo aveva riconosciuto dalla voce.
“Devono farvi un paio di domande” continuò Checco. “Sai chi erano?” chiese Giuseppe.
“Forse quelli della Mala del Brenta” rispose Checco.
“Questo è un colpo progettato per bene” continuò l’agente investigativo. “Checco, sai cosa stavamo trasportando?”.
“Niente Beppe, non c’era niente di valore”. “E allora perché?”
“Non lo so, forse si aspettavano dell’altro” “Ora seguimi Beppe”
Giuseppe si voltò verso Carmine, che era scortato da un altro agente.
“Mino” disse.
“Beppe” rispose lui.
“Domani vieni a mangiare gli gnocchi alla romana”.
Matilde Gnasso